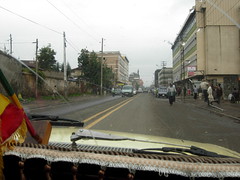Quando la guerra civile arrivò a Kinshasa, nel 1997, le zone più combattute della città erano quelle vicine alle principali arterie di comunicazione. Una è la strada che viene dal Bas Congo, ed entra in città da Mont Ngafula. Un'altra è la strada che arriva dal Bandundu, costeggia l'aeroporto di Ndjili, e poi all'ingresso della città diventa Boulevard Lumumba, lo stradone spartiacque fra i quartieri di Kingasani e Masina.
I congolesi non parlano spesso di quegli anni. I missionari invece li raccontano con un'ammirevole serenità, malgrado tutto. Padre Stefano ci ha raccontato sorridendo di quando a Mont Ngafula uscì in strada e si mise in mezzo fra l'esercito di Kabila e quello di Mobutu, facendo da interprete fra i Banyamulenge (i Tutsi congolesi) di Kabila che parlavano Swahili e i soldati di Mobutu, per lo più dei Bandala, che parlavano Lingala. Cercava di ottenere una tregua, ma non è andata benissimo, e racconta senza perdere serenità anche di come è scappato a gambe levate, e della paura cieca di quegli attimi.
“Non sono come i militari romantici dei film o dei romanzi, questi non hanno nessuna morale”, dice Padre Santino. Ci racconta della facilità con cui uccidevano i civili, degli stupri, della suora Anuarité morta nel nord del Congo per aver rifiutato di concedersi a un soldato. I bambini-soldato, poi, erano anche più spietati degli adulti, “per loro uccidere è un gioco”.
Racconta sempre con leggerezza, correndo veloce sui singoli argomenti, “ché se ti metti a ripensarci poi ti prende la paura”.
Per la gente del nostro quartiere quelli sono stati anni di angoscia. Durante la seconda guerra i soldati dell'esercito di Kabila, che nel frattempo aveva preso il potere, venivano nelle parcelles a cercare i “rwandesi”, che poi voleva dire identificare chiunque avesse tratti somatici vicini a quelli rwandesi. Gli sfortunati che avevano dei lineamenti sospetti si ritrovavano con un pneumatico imbevuto di benzina infilato intorno alla vita, come una cintura, e finivano bruciati vivi, in strada.
Quelle stesse strade oggi sono piene di bambini. Quando piove è una festa, escono tutti a piedi nudi a giocare nelle pozzanghere o sotto gli scrosci d'acqua, rischiando ogni volta di rimanere fulminati su qualche cavo elettrico mal sotterrato. Scene che raccontano un quartiere che è ancora molto lontano da una qualità della vita dignitosa, almeno secondo le nostre concezioni, ma che è ben lontano anche dalla paura che doveva vivere alcuni anni fa.
Cerco di immaginare come dev'essere stata l'infanzia di quelli che oggi hanno diciotto anni. Sono gli stessi che spesso in strada ti guardano con aria diffidente, lanciando occhiate di sfida che trasudano una voglia insoddisfatta di rivincita nei confronti di quelli che identificano facilmente come ricchi e potenti.
La parola mundele, quando sono loro a usarla, assume tutta la sua forza dispregiativa. Un razzismo di ritorno che, ironicamente, si sprigiona proprio in una parola che è nata dalla storpiatura di “model”, espressione di sudditanza con cui i congolesi chiamavano i colonizzatori belgi.
Mi chiedo come mi comporterei al posto loro, se fossi nato congolese e cresciuto a Kingasani negli anni novanta, fra i pillages del mobutismo in declino e le guerre che si sono succedute in seguito. Come sarei stato se avessi visto quello che hanno visto loro? Cosa avrei provato nei confronti dei bianchi, dei potenti, di quelli che hanno tutte le possibilità e sfruttano le risorse del Congo per portare ricchezza all'estero, di quelli che quando la situazione si fa difficile possono prendere un aereo e andarsene? C'è da rimanere stupefatti, in fondo, a pensare a quella gran parte di ventenni che ci accolgono con amichevolezza e allegria appena ci conoscono.
Quando uno arriva in questi luoghi all'inizio è sopraffatto dagli odori, dai paesaggi urbani spesso disperanti, dagli atteggiamenti più superficiali dell'umanità varia e densissima che ti si presenta davanti.
Più mi sforzo di andare al di là di questo primo velo, cercando di vedere queste strade in una prospettiva di qualche anno, e più mi sembra finalmente di intravvedere anche un bicchiere mezzo pieno, dietro all'apparenza di questo paese a prima vista senza via d'uscita, avvinghiato sull'immobilismo dei suoi mali endemici che, sfortunatamente per i congolesi, si sposano troppo bene con gli interessi dei paesi ricchi.
Comincio a capire l'allegria di questa gente che, cresciuta in una perenne mancanza di serenità e di pace, ha da poco ritrovato almeno la speranza e stabilità, che ne sono già un primo e fondamentale surrogato.
“Non vi scoraggiate”. Mi tornano alla mente queste parole, belle e del tutto inattese, che due anni fa mi sentii dire da una ragazza-poliziotto, dopo che il suo capo ci aveva appena fatto passare un brutto quarto d'ora. Sono le stesse parole che Marco, senza saperlo, ha ripetuto ai ragazzi che gestiranno il nostro centro a Kingasani. Un incoraggiamento che abbiamo sostenuto anche noi, e che va al di là del risolvere i problemi con un disco fisso o con un'installazione, visto che l'entusiasmo, il senso di appartenere a una comunità e la voglia di sacrificarsi per costruire qualcosa saranno necessari in ogni aspetto del loro impegno.
I segni positivi ci sono tutti, ma c'è anche la consapevolezza che i segni qui sono sempre precari e temporanei, e che la speranza può presto diventare disillusione, in un paese stremato che si attende molto da questo nuovo regime. Distruggere è sempre più facile che costruire, e basta poco per mandare in fumo i progetti e i sacrifici di molti, e tornare indietro, nel baratro dell'ognun per sé.
A volte, partendo da queste considerazioni spicciole, mi prendeva un po' di sfiducia sulla reale portata di un progetto di cooperazione come il nostro, in un posto in cui basta una decisione storta presa da un potente in occidente per mandare all'aria quello che s'è costruito con fatica in mille progetti. Ne parlavo con Marco, una mattina, tornando da Gombe in uno dei nostri viaggi, e i suoi racconti m'hanno fatto riflettere.
Ritorno da Kinshasa con un po' di fiducia in più. In un paese dove la la voglia di ricostruire si regge su un filo precario, il nostro minuscolo progetto di cooperazione, realizzato dove non c'era nulla, ora mi sembra qualcosa di significativo, non solo per il progetto in sé, ma anche semplicemente per aver portato un'esperienza di cooperazione in più in un contesto in cui non ce n'erano molte, e aver dimostrato che costruire qualcosa insieme è possibile.